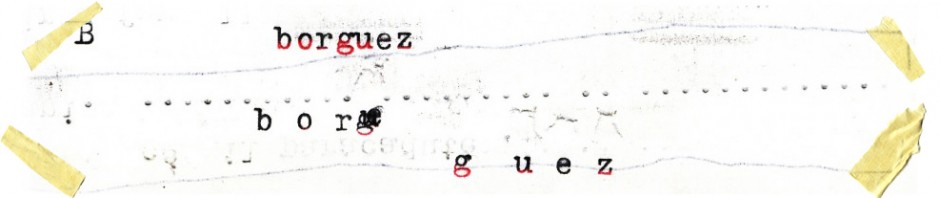poco più di un mese addietro tramutai questo blog in una minuta cassa di risonanza per estendere il più possibile la richiesta d’aiuto da parte degli organizzatori del festival sardo Ai Confini Tra Sardegna e Jazz. da lì a qualche giorno giunse, per fortuna, la notizia che un accordo era stato trovato e che il festival avrebbe avuto degno svolgimento. confessai il mio rammarico per non potervi partecipare ma non feci mancare il mio seppur minimo sostegno. fra i benevoli lettori di queste pagine ero certo che avrei trovato sostenitori, appassionati e frequentatori di questo prestigioso festival (vado estremamente fiero delle persone che gentilmente passano da qua, mi si permetta la confessione): e fra loro iniziai una conversazione (diciamo) privata con uno di loro.
SfasciaCarrozze (con le minuscole o le maiuscole e d’ora in poi soltanto s.c.) sostiene coltamente le vicende di queste sponde da parecchio tempo: non appena ho saputo che a quel festival avrebbe partecipato mi sono permesso di chiedergli un rapporto (un resoconto? un liofilizzato? una cronaca?) dalla platea di quella manifestazione. il fatto che abbia amabilmente accettato mi conferma la natura gentile e cordiale dei lettori del blog ed in particolar modo della sua, sia ben detto. e per questo lo ringrazio.
e allora ecco di seguito le parole (e le foto) di s.c., che a quel festival ha assistito e così lo ha raccontato a me e a chi vorrà leggerne. ancora grazie. buona lettura.

Da ateo convinto posso affermare senza remore che quest’anno l’organizzazione, ma soprattutto l’effettivo svolgimento, del Festival in quel di S.Anna Arresi, giunto alla ventottesima edizione, ha assunto i crismi dell’autentico miracolo: dato per definitivamente sospeso, a causa dei soliti insoluti ergo allucinanti problemi di natura meramente istituzional-economica-burocratica a meno di venti giorni dalla data di previsto inizio la rassegna infine e nonostante tutte le difficoltà ha preso il via mantenendo in larga parte invariato il cartellone ufficiale a suo tempo calendarizzato grazie anche e soprattutto alla cocciutaggine del pàtron Basilio Sulis, dei suoi fedeli sodali et altresì alla comprensione e solidarietà degli artisti chiamati a calcare il palcoscenico prospicente l’emiciclo posizionato sotto l’arcaico Nuraghe Arresi.
Per una concatenata serie di congiunture astrali sfavorevoli ho potuto presenziare solo a un miserrimo terzo delle nove serate previste in cartellone: d’altronde sono oramai abituato a considerare normale se non del tutto soddisfacente la percezione della ricolma parte inferiore del famigerato bicchiere mezzo pieno.
Ma ciancio alle bande: il Festival inizia di fronte a un non nutritissimo pubblico la sera del 22 agosto con i promettenti giovan(ssim)i cosmodelici afro-jazz-punksters provenienti da South-East London, United Vibrations. Ensemble composto dai tre fratelli Dayes rispettivamente impegnati su batteria, basso elettrico e fiati e dal sassofonista Wayne Francis: un set di poco meno di un’ora nel quale hanno snocciolato con fresca naturalezza larga parte del proprio non vastissimo repertorio conosciuto (il notevole album di debutto “Galaxies Not Ghettos” risalente al 2011 e “We Never Die” EP di recentissima coniazione) con un progressivo coinvolgimento della platea; piacevolissimo, tra i tanti, il rimaneggiamento in idioma spaghettricolorico di “No Space No Time” divenuta per l’occasione “Non c’è spazio Non c’è Tempo” con conseguente ilarità e gradimento dei sempre più ammaliati astanti. Davvero un ottimo set per un ensemble tanto giovane quanto in prospettiva assai promettente come peraltro dimostra l’EP, gratuitamente scaricabile dal bandcamp, del gruppo britannico. Giusto il tempo di smobilitare la parca strumentazione dei giovani virgulti della Terra d’Albione che prende subitaneo possesso del palco, inizialmente in maniera quasi timida, l’istrionico vocalista d’origine trinidadense Antonio Giuseppe (Anthony Joseph n.d.r.) coadiuvato dalla davvero possente Spasm Band; nell’arco di dieci minuti primi il funk corposo e viscerale del quintetto istiga alla spasmodica/allegra danza anche i più statuari ergo inamidati spettatori presenti: letterale tripudio sotto & sopra il palco! Le umane gesta del James Brown, almeno per una volta, possono essere adeguatamente citate senza creare scompensi che osino distogliere dal pacifico riposo le inanimate spoglie del vocalist della South Carolina: qua fuori esiste ancora qualcuno in grado di onorarne degnamente, fatti i debiti distinguo del caso, fasti & gesta.

Orbene saltando a piè pari i [non visti] The Heliocentrics – di cui mi testimoniarono on stage un gran bene, ahimé – giungiamo alla serata del sabato ventiquattro nella quale sono previsti dapprima il particolare progetto denominato Natural Information Society, trio guidato dal felpato polistrumentista Joshua Abrams indi a seguire il folle duo Talibam!, coadiuvati eccezionalmente in questa sede da Mr. Peter Evans and Sir Alan Wilkinson, rispettivamente impegnati a devastare trombette varie e sassofoni assortiti. Il trio che dovrebbe scaldare (o anche raffreddare, ça va sans dire) l’audience, anche per l’occasione non particolarmente foltissima, accomodatasi tra i gradoni prospicenti il palco sviluppa una serie di brulli et tortuosi mantra magnetico-magmatici nei quali l’harmonium della inamovibile Lisa Alvarado si compenetra agli ordinati contrappunti percussionistici orditi da Chad Taylor, all’interno dei quali il bassista della scuola di Chicago costituisce un solido, diversificato quanto insistito tappeto ritmico grazie all’ausilio di essenziali quanto arcaiche strumentazioni di matrice africana oltre che dell’abituale contrabbasso. Un modulo espressivo decisamente autoctono quanto forse un filino, diciamo così, monotematico e, almeno per quanto mi riguarda, non esattamente del tutto epidermicamente coinvolgente: i convinti applausi dalla platea e il bis richiesto a gran voce testimoniano esattamente il contrario di quanto appena sostenuto.

E così dopo aver incrociato quel mattacchione di Matt (Mottel) spacciare deliberatamente autoctoni vinili, ciddì e t-Scerts all’interno del microchioscobar (qualcuno scambiandolo per uno dei baristi gli ha pure chiesto due birre..) ecco salire sul palco la premiata ditta Shea+Mottel in minacciosa formazione allargata: conoscendo la eterogenea follia dei nostri – basti ricordare il loro avulso disco Rap pubblicato lo scorso anno – non sapevo esattamente dove sarebbero andati a parare e, puntualmente, hanno sconvolto l’audience con un letterale uragano di leggiadre cacofonie assortite d’ambito squisitamente frì-gezz sotto forma di quattro pachidermiche suites (più bis di quasi mezz’ora) nei quali i quattro scellerati bisonti di cui sopra non hanno dimostrato la benché minima intenzione di far prigionieri: il tornado emesso dalla amplificazione lascerà non a caso liberi parecchi di abbandonare prematuramente la postazione; i quattro maudits sembrano divertirsi un mondo lassù: quiggiù invece taluni hanno la sensazione che il confine, talvolta labile in ambiti artistici così incompromissori, della presa per il fondello possa talvolta venir travalicato senza particolari avvisi: spezzoni da ventiminutiprimi dove la batteria di Mr. Shea resta in infinita-rullata-perenne e le tastiere di Mottel vengono più percosse e smanacciate che prestidigitalmente suonate possono provocare qualche dubbio (o forse, per qualcuno, certezza) in tal senso: per quanto mi riguarda concerto “divertente” quanto spakkaossa, magari consigliabili a gente dall’udito già pesantemente leso se non irrimediabilmente compromesso.
E così giungiamo all’ultimo tassello della XXVIII edizione del Festival, probabilmente l’evento più atteso dagli appassionati di jazz e dintorni che sono passati per la Piazza del Nuraghe nel corso degli ultimi dieci giorni; protagonista sul palco è l’immortale e multicromata cometa denominata Sun Ra Arkestra che fa la propria seconda comparsa nei cieli stellati di S.Anna Arresi a distanza di 24 anni dal primo passaggio avvenuto nell’oramai lontano 1989. La direzione dei lavori nelle ultime due decadi è stata affidata al giovane virgulto Marshall Allen che alla tenera età di ottantanove primavere si diverte a passare senza alcuna difficoltà dal sax alto al flauto, al clarinetto, kora e evi. Dimenticavo: tra uno strumento e il successivo riesce a prestare la propria ugola al canto di supporto alla corpulenta Tara Middleton! Il palinsesto promulgato dall’ensemble, attualmente stabilizzatosi intorno agli undici elementi, non sembra essere minimamente intaccato dal tempo, anzi: l’Arkestra da subito ammalia e trascina la finalmente folta platea riunita nell’emiciclo con una corposa performance di quasi due ore a base di un vivace e diversificato set che passa agevolmente da brani swing-oriented a più rudi scorrerie free con un orecchio rivolto, necessariamente, al passato e l’altro teso decisamente al futuro.

Un ottimo concerto quale degna chiusura di una manifestazione che, occorre sottolinearlo e affermarlo una volta di più, nell’annus domini MMXIII qualitativamente si afferma e conferma come uno tra i più interessanti festival jazz italiani se non continentali; visti i chiari di luna nefasti che hanno caratterizzato l’appropinquarsi all’evento, si spera che l’anno venturo sia possibile avere l’opportunità di poter assistere alla ventinovesima edizione. Anzichénò
s.c.

 Kada Zvona Zvone
Kada Zvona Zvone