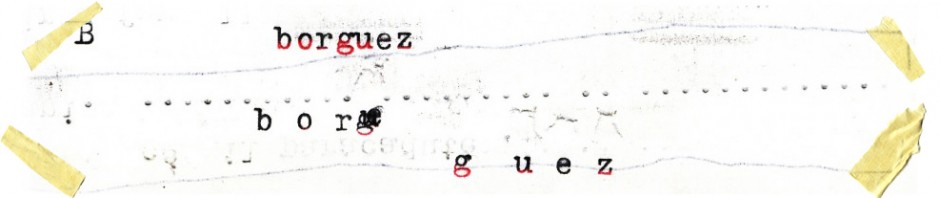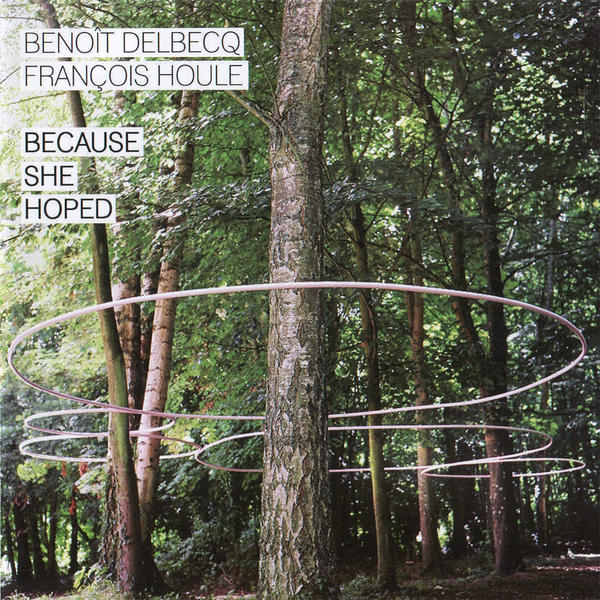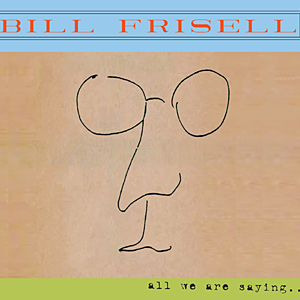il superlativo del titolo non è mio, pur condividendolo appieno; battesimo sinceramente immodesto e scomodo come questi tre musicisti lo sono per la musica contemporanea. un supergruppo per realizzare un superdisco: come nei sogni malsani degli avanguardisti più intransigenti. in realtà i tre mescolavano già da un paio d’anni i loro deliri sui palcoscenici d’europa frequentando festival e club abbarbicati al limite del continente. dopo alcuni video trapelati dal colabrodo della rete e qualche registrazione clandestina ecco dunque giungere il superdisco accasato, manco a dirlo, per la prestigiosa etichetta belga Sub Rosa.
 che succede dunque quando le peregrinazioni immaginifiche di Jac Berrocal si incontrano con quelle di David Fenech passando per le corde vocali dell’illustre Ghédalia Tazartès? capita che si venga trasportati in un non-luogo indefinibile da meridiani e paralleli e pure da clessidre: assomiglia all’avamposto spinto ai confini delle nostre frontiere ignaro del fatto che non vi sia più nulla da difendere o da esplorare dopo che tutto è divenuto dopo, post. oltre i suoni delle avanguardie, oltre la forma canzone, oltre le tradizioni popolari e oltre il linguaggio e le sue forme.
che succede dunque quando le peregrinazioni immaginifiche di Jac Berrocal si incontrano con quelle di David Fenech passando per le corde vocali dell’illustre Ghédalia Tazartès? capita che si venga trasportati in un non-luogo indefinibile da meridiani e paralleli e pure da clessidre: assomiglia all’avamposto spinto ai confini delle nostre frontiere ignaro del fatto che non vi sia più nulla da difendere o da esplorare dopo che tutto è divenuto dopo, post. oltre i suoni delle avanguardie, oltre la forma canzone, oltre le tradizioni popolari e oltre il linguaggio e le sue forme.
Superdisque (Sub Rosa, 2011) arruola la tromba di Berrocal assieme alla chitarra di David Fenech a dividersi i turni di guardia con i deliri di Tazartès. loro tre a presidiare l’avamposto servendosi di ammenicoli e brandelli di memorie sonore, stralci di un tempo passato, ricordi. di notte, nel cabaret del refettorio i tre improvvisano ballate e canzoni mal digerite servendosi del generatore che sputa l’ultima corrente elettrica disponibile. bagatelle dopo il massacro, rigurgiti di blues, reticenze free si mescolano con incedere marziale a ricordi popolari, canti di pastori erranti, agli ultimi sussulti silicei di qualche congegno elettronico.
Ghédalia Tazartès mugugna la sua lingua ieratica e inesplicabile sopra tappeti di blando stordimento elettrico. lingua incongrua, spuria, che solo a tratti rammenta quel francese malsano biascicato nei sogni sudati al chinino nel deserto africano dei legionari. ma la sensazione di trovarsi esattamente da nessuna parte persiste: un piccolo aleph malato.
una piccola cosmogonia portatile di sciamanesimo da consultare ogniqualvolta assale la sensazione di smarrimento e di perdita, una mappa per conoscere le transumanze dei popoli ben prima che tutto venisse spazzato via inghiottito in un niente assordante.
si potrebbe definire disco dell’anno se solo si sapesse in che anno ci si trova. tempo indefinibile, imprendibile nello spazio circostante che si scruta dalla garitta.
Superdisque appunto.